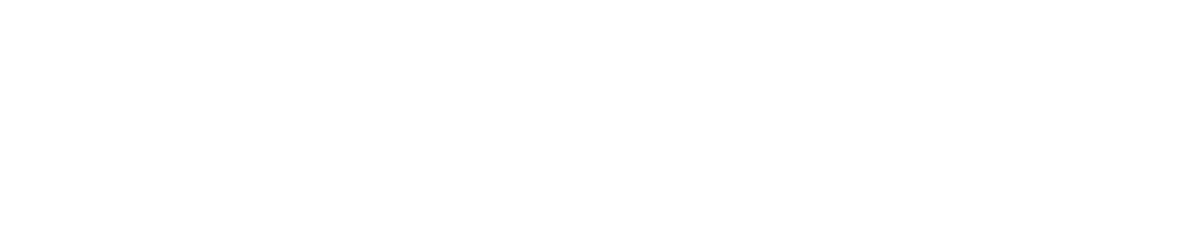Il batiscafo Trieste fu progettato da Auguste Piccard e suo figlio Jacques, fu un’impresa ingegneristica rivoluzionaria. Questo veicolo sottomarino senza equipaggio fu fondamentale per esplorare le profondità oceaniche, raggiungendo profondità mai viste prima. La sua caratteristica principale era una sfera di acciaio resistente alla pressione, progettata per sopportare le immense pressioni dell’abisso marino. Il Trieste divenne famoso per aver raggiunto il punto più profondo degli oceani, la Fossa delle Marianne, nel 1960, con Don Walsh e Jacques Piccard a bordo. Questa storica immersione aprì nuove frontiere per la ricerca oceanografica, fornendo preziose informazioni sulla vita e le condizioni estreme presenti nelle profondità marine. Il Trieste rimane un simbolo di coraggio umano e ingegno tecnologico nell’esplorazione degli abissi. La costruzione del batiscafo venne eseguita in Italia, a Trieste, nel Cantiere San Marco dei Cantieri Riuniti dell’Adriatico, la sfera di immersione costruita in acciaio inossidabile alle acciaierie di Terni e oblò in quarzo troncoconico realizzato presso le officine Galileo di Firenze, e al cantiere navale di Castellammare di Stabia, dove la sfera fu saldata allo scafo. Come scrisse il Piccard: “E’ dunque Castellammare che inizia l’adunata dei numerosi elementi che, riuniti, formeranno il Trieste.” Ad inizio del gennaio 1953 inizia il viaggio, il percorso fu completato in 11 giorni ad una velocità di 15 km orari con la classica scorta di motociclisti della polizia stradale che provvidero alla sicurezza del convoglio e dei viaggiatori. Arrivati a Castellammare gli stabiesi guardarono con interesse quel misterioso apparecchio, molti intuirono che si trattava di un sottomarino. Il costruttore svizzero ed il figlio vissero e lavorarono per diverso tempo nella cittadina stabiese. Castellammare di Stabia, primo agosto 1953, giorno della festa nazionale svizzera, le insegne salgono sull’albero del Trieste: il tricolore della Marina italiana e la croce bianca su fondo rosso della bandiera elvetica. Il batiscafo è ancora sulla banchina sotto la direzione degli ingegneri Giulio Salvio e Armando Traetta(decorato con medaglie d’argento e di bronzo al valore militare nell’ultima guerra e docente presso l’I.T.I. Leonardo Fea) due tra i più stretti collaboratori degli scienziati svizzeri. La gru della Navalmeccanica afferra l’anello di sospensione del batiscafo. Tutti gli operai e impiegati sono presenti. Come tradizione vuole il battesimo deve essere eseguito ma il Piccard: “… non riesce a capire quale nesso ci sia tra il frantumarsi della bottiglia di champagne e l’augurio del felice avvenire”. (Dalla stratosfera agli abissi marini , A.Piccard, Garzanti ,1955) Decide quindi di sopprimere questa tradizione e chiede a Padre Agostino di aspergere il batiscafo con acqua benedetta. La gru girando su sé stessa depose il batiscafo sull’acqua. L’11 agosto finalmente il Trieste può immergersi anche se non si trattò di una vera e propria immersione in quanto la profondità dell’acqua era solo di otto metri e venti. A tutti gli effetti può considerarsi la prima immersione, a cui seguiranno quella del 13 agosto sempre a Castellammare a 16 metri ed il giorno seguente, tramite il rimorchiatore d’alto mare Tenace lo condusse al largo per raggiungere i 40 metri. Quella profondità consentiva in caso di bisogno di poter usufruire dei palombari. Seguirà poi quella a sud di Capri a 1.080 metri. Dopo questa immersione il batiscafo tornò a Castellammare per essere sottoposto ad un esame sulla tenuta. Il 5 ottobre 1953 nel Cinema Nazionale gremito in ogni ordine di posto fu annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellammare di Stabia ad Auguste ed Jacques Piccard, seguita dall’atto ufficiale della ratifica nella sala consiliare di Palazzo Farnese.
A cura di Giuseppe Plaitano