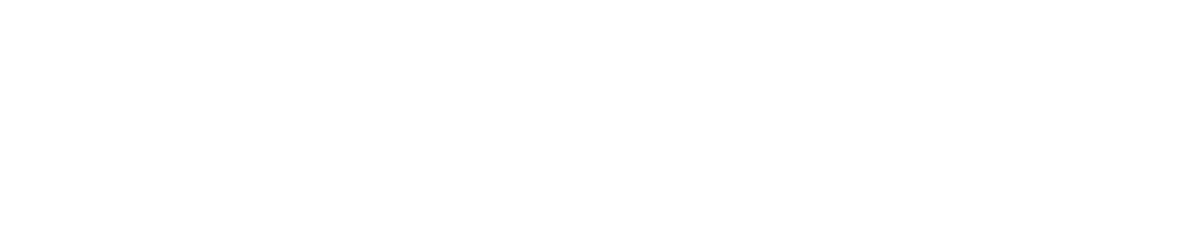Sorrento, da sempre meta turistica d’élite, ha sviluppato un’economia basata sul turismo, mentre Castellammare di Stabia ha avuto un passato industriale più radicato, con una tradizione cantieristica e termale. Queste differenze hanno creato una sorta di divario sociale, che talvolta, ancora oggi, si manifesta in forme di ”campanilismo”. Risale all’epoca romana “l’antagonismo” tra Castellammare di Stabia e Sorrento, affonda le sue radici in un contesto storico complesso, caratterizzato da dispute giurisdizionali e tensioni politiche tra le due città. Per il passato anche la tematica della giurisdizione ecclesiastica in qualche circostanza ha rappresentato un punto di attrito. I vescovi di Sorrento rivendicavano autorità su determinate aree che rientravano anche nell’interesse della diocesi di Castellammare. Le dinamiche politiche in seguito, all’epoca del Regno di Napoli, che esercitava un forte controllo sulle nomine ecclesiastiche, complicarono ulteriormente il contesto. A ciò andavano sommate le influenze delle famiglie nobiliari locali e le alleanze politiche che potevano, in qualche caso, fare da ago della bilancia sulle decisioni dei vescovi. Ma arriviamo ai nostri giorni… l’odierna arcidiocesi nasce nel 1986 con la bolla “Quamquam Ecclesia” di papa Giovanni Paolo II che sancì l’unione delle due precedenti sedi, l’arcidiocesi di Sorrento e la diocesi di Castellammare di Stabia, entrambe storicamente attestate dalla fine del V secolo. È degli inizi del XVIII sec. una disputa ecclesiastica documentata tra i due vescovi. Il presule di Castellammare all’epoca dei fatti era Mons. Tommaso Milante (1743 – 1749), noto per la sua determinazione nel difendere i diritti della sua diocesi. A Sorrento altrettanto risoluto nel far valere le proprie prerogative c’era Mons. Filippo Anastasio. Filippo Anastasio fu vescovo di Sorrento dall’11 aprile 1699 al 13 dicembre 1724 (dal 20 dicembre 1724 fu nominato patriarca titolare di Antiochia). Per farsi apprezzare dai suoi diocesani nel 1731 scrisse un’opera sulla storia civile ed ecclesiastica di Sorrento intitolata: Lucubrationes in Sorrentinorum ecclesiasticas, civiles antiquitates. Al vescovo stabiese di sicuro non fece piacere leggerlo e forse anche per render giustizia alla città redisse: ”De Stabia, Stabiana ecclesia, et Episcopius ejus”. Milante, purtroppo non ebbe modo di vederlo pubblicato, solo l’anno dopo la sua dipartita il testo fu dato alle stampe. Trascorre più di un secolo, siamo nel 1845, Francesco Alvino in “Viaggio da Napoli a Castellammare” inspiegabilmente ebbe a scrivere del tomo che il vescovo di Sorrento Anastasio aveva elaborato il secolo precedente: “…più ch’era in poter suo, le glorie de’ Sorrentini e l’ decoro della sua Chiesa, sdrucciolò nel falso togliendo alla città di Castellammare di Stabia i suoi pregi, e dicendola terricciuola, dipendente in ogni tempo, così civilmente che ecclesisticamente, da quella di Sorrento. Se ciò spiacque ai Castellonici è inutile ch’io ve l’ dica…”. L’Alvino riguardo poi al testo del Milante, scrisse che era un’opera dignitosa, ragionata anche se calda e appassionata al tempo stesso. Ma c’è ancora qualche altro tassello da mettere a posto… L’anno successivo alla pubblicazione del tomo del Milante il vescovo di Sorrento era Ludovico Agnello Anastasi, nipote del precedente patriarca, che colto nell’onore, credendo che il vescovo stabiese avesse in qualche modo intaccato “la dignità” dello zio, d’impeto scrisse in brevissimo tempo un altrettanto voluminoso tomo dal titolo: Animadversiones in librum fratis Pii-Thomae Milante Episcopi Stabiensis, de Stabia, Stabiana Ecclesia et Episcopis ejius ( Neapoli 1751). Quel libro si rivelò, come scrisse l’Alvino, “null’altro che una cattiva azione”, scendendo nel puerile, forse il tutto dettato dalla rabbia in difesa dello zio. A difesa del Milante, all’epoca della vicenda, accorse tra gli altri un giovane medico, Gaetano Martucci, nato a Castellammare nel 1730. Martucci aveva studiato nei seminari di Lettere e Sorrento e si era laureato in medicina all’età di 21 anni. Più che medico fu un autore di studi storici e in particolare dei privilegi concessi nel corso degli anni alla cittadina stabiese dai regnanti. È innegabile che il campanilismo abbia contribuito a forgiare l’identità unica di entrambe le città, continuando a stimolare un vivace senso di appartenenza. A mantenere vive le radici culturali e il valore delle tradizioni locali, elementi che ci rendono unici e ci legano al nostro territorio.
A cura di Giuseppe Plaitano